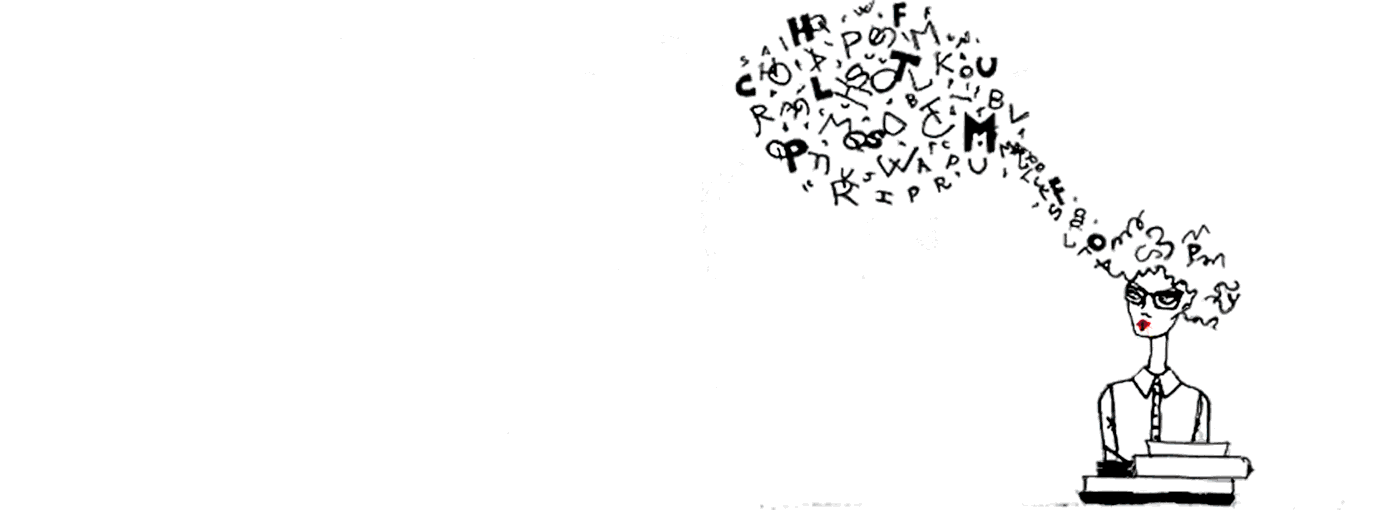Non importa quanto io riempia di persone, impegni, fiori o di mare la mia vita. Alla fine, le arsure e i vuoti mi raggiungono sempre e, a me, non resta altro che attraversarli perché è così che faccio da tutta una vita. Sono momenti di profonda fragilità, durante i quali ho paura di respirare, di vivere, a livelli talmente paranoici che la morte mi sembra l’unica soluzione possibile. Più sono nel vuoto, più chi mi ama cerca di trascinarmi via da lì. Fa più paura vista da fuori, non è così?
“Sei triste”? Ho perso il conto delle volte nelle quali me lo sono sentita chiedere. Cosa è la tristezza in fondo se non l’assenza di gioia? O, forse, essere tristi significa semplicemente sentire la pena e la fatica di vivere? Dove sono le sfumature quando ne hai bisogno?
“Sei felice”? Nel senso che non sono triste? Io, per la maggior parte del tempo, sono e basta. L’esigenza di dover sempre dare un nome ai sentimenti, la capisco perché non sono mai a corto di parole, ma allo stesso tempo mi genera ansia. Mi mette in subbuglio dico davvero. Quando sento, io sento tutto che spesso equivale a non sentire niente. È più un vivere nel farneticante terrore che qualcosa di tremendo si sia nascosto dietro un angolo della mia vita. Ne ho voltati a decine di migliaia, sono ancora in piedi, eppure, sono certa che al prossimo troverò quello che mi manderà in mille pezzi. Vivo, dunque, nell’attesa? La maggior parte del tempo sì.
I primi ricordi di me che faccio pensieri così oscuri risalgono all’infanzia e per oscuri intendo sentire attraverso ogni filamento di carne che non hai voglia di sorridere e, nonostante tutto, farlo perché la gente… oppure, non comprendere il mondo che ti circonda, desiderare solo di correre a nascondersi in un cantuccio e non uscire mai più, invece, mostrare il tuo sorriso più spassoso perché va tutto bene, va tutto benissimo!
È una sensazione di paralisi che in qualche modo impari a nascondere a tutti, persino a te stessa.
È un po’ timida dicono di te durante l’infanzia, è di natura malinconica durante la tua adolescenza, è depressa quando ormai hai quasi quaranta anni. Scomodando termini clinici come se il solo enunciarli servisse ad “aggiustarti”, a dare un nome a questa letargia emotiva che il mondo detesta vedere in te. Tua madre che ancora oggi non riesce a capire cosa ci sia che non vada in te e quando ti vede inabissarti alza gli occhi al cielo.
Non saprei dire quale sia la verità. So che lo stato di inattività emotiva e fisica è una parte di me preponderante e, credetemi, la odio più di quanto la detestiate voi che mi guardate nella mia immobilità. L’ho nascosta a lungo e ho creduto di combatterla con ogni strumento a mia disposizione, spesso quelli più sbagliati. Come in quel gioco nel quale c’è questo campo con delle buche e tu devi scoprire da quale buca salterà fuori la talpa. Sei lì, che cerchi di convogliare tutte le tue energie in quel maledetto martello in un perfetto connubio tra cuore e cervello. L’ho sempre trovato terrificante. Una buca lì, aspetta, la riempio prima che spunti la talpa, con una sigaretta che copra il disprezzo che nutro per me stessa a soli dodici anni, ora sì che mi troveranno una che non ha tempo per avere paura di crescere. Oh, guarda lì un’altra buca, ho proprio lo spinello adatto e per quell’altra ecco la birra giusta o sbagliata, poco conta l’importante e non sentire più di vivere in un corpo di vetro avendo un’anima di piombo. E poi parlare e parlare e parlare e sovrastare il silenzio e i miei sto alla grande! Sto alla grandissima. Nutrire l’illusione che i buchi vadano riempiti con l’amore degli altri e lanciarsi in un’indefinita sequenza di storie d’amore sbagliate non perché sbagliati fossero loro, ma perché sbagliato era ed è, non bastare a se stessi. E cosi via, via fino alla voragine che credevo di colmare con un matrimonio sbagliato con una persona meravigliosa e la maternità che, contro ogni mia aspettativa, mi sono scoppiati in faccia come due enormi granate. Che illusa! Sono una cazzo di fetta di groviera! Sono la stessa ragazza di sempre, con i suoi buchi di sempre che cerco di imparare a rispettare ogni singolo giorno, esercitando la comprensione, la consapevolezza e la compassione per me stessa. Ma cado, spesso. Troppo. Perché è, azzarderei dire, naturale essere empatica con il resto del genere umano, ma quando si tratta di me tutto cambia perché che diritto ho io di lamentarmi in fondo? Cosa mi manca? Come oso scomodare termini quali depressione, infelicità, io che ho tutto e, diciamocelo, molto di più di quel che mi sono guadagnata? Allora, mi convinco che è solo la mia natura, che la paralisi che sento anche ora mentre sono qui a scrivere è solo parte del mio normale ciclo vitale e nel raccontarmi questa solfa, è un po’ come prendermi a sberle da sola, lo so, ma non mi sembra di avere molta scelta. Elimino la scrittura, mi dedico solo alla mia piccola V, mangio solo cibo alcalino, elimino l’alcol e, nella privazione, mi illudo di averla risolta.
Quando, però, nonostante la mia irreprensibile condotta, i vuoti tornano, mi sento confusa, arrabbiata e più di tutto delusa da me stessa che, ancora una volta, ho dimostrato di non essere in grado di vivere una vita normale.
Lo so, la normalità è sopravvalutata. Lo so, sentirsi giù va bene, ma il mio abituale modo di reagire ai vuoti, si manifesta nel bisogno di controllare tutta la vita che mi circonda, inclusi il mio corpo e le mie emozioni. Se sono in controllo posso prevenire tutto: il dolore, l’abbandono e, più di tutto, posso in caso di errore, biasimare solo me stessa senza dover trascinare altri nel mio tribunale della ragione, di norma integerrimo. Roba che Kant impallidirebbe.
So che è tutta un’enorme balla e che più mi illudo di controllare, più sono una trottola impazzita. Sono consapevole di dover dimostrare compassione a me stessa, ma per quanto io sappia che le aspettative che nutro per me siano irrealizzabili e, comunque, rasentino il patologico per qualcuno che voglia vivere una vita serena, mi risulta impossibile farlo perché, semplicemente, io sono così. Non posso ammettere a me stessa di essere depressa, perché io non ammetto di poter fallire.
So che essere depressi non significa fallire, perché, tecnicamente, è qualcosa che accade all’interno del delicato equilibrio chimico del cervello sul quale non ho la minima speranza di avere controllo, ma è ciò che sento e così, ritorno alle arsure, ai vuoti, ai cicli e alle inquietudini.
Elimino gli zuccheri
Elimino l’ alcol
Elimino la scrittura
Mi tatuo qualcosa di nuovo
Faccio meditazione
E resto sempre qui ad esercitarmi con la compassione per me.
O, almeno, cerco di imparare.
Ogni, singolo, giorno.