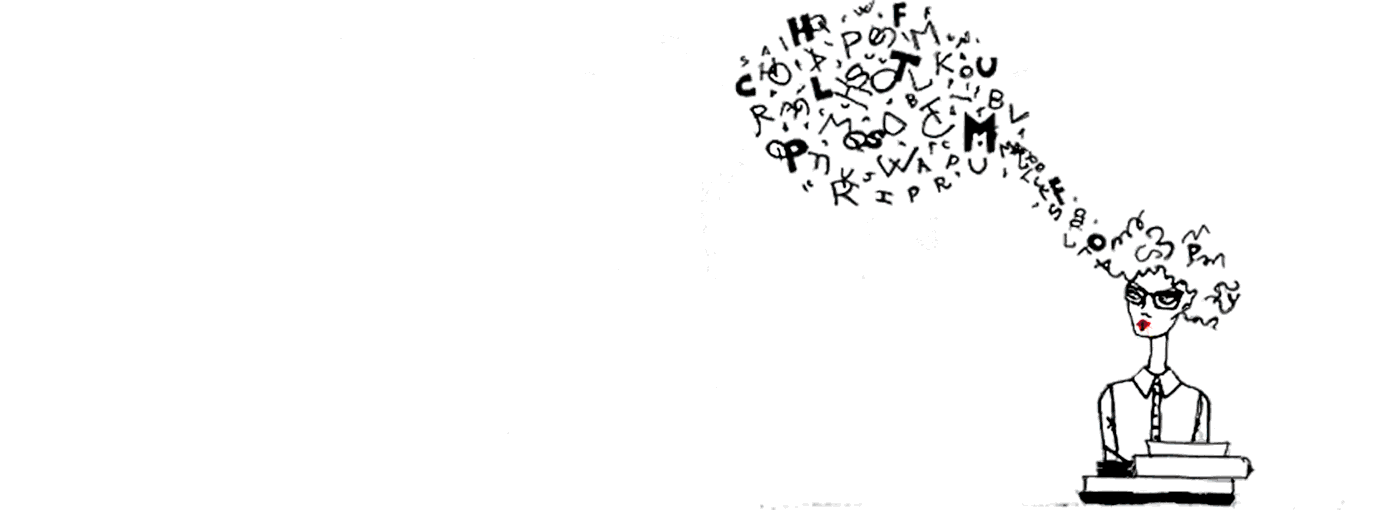Ho imparato che le persone non le puoi archiviare come con le chat di whatsapp.
Non basta metterle da parte, come con i messaggi che scegliamo di non leggere.
Quei messaggi sono lì. Il nostro potere, semmai, è tutto insito nel non leggerli ancora e ancora, tranne poi, andare inevitabilmente a rileggerli, così che ti viene da chiederti a cosa sia servito archiviarli. Non so la vostra, ma la mia chat di whatsapp dei messaggi archiviati, è direttamente proporzionale, alla lista di rapporti che cerco di chiudere nella vita reale.
Ecco, il problema con i messaggi archiviati è, appunto, che sono archiviati. Negati alla vista. Nascosti. Retrocessi. Infamati per certi versi ed è lì, dove non si può, che la mente continua ad andare. Tranquilli, non è che noi non siamo capaci di trattenere il dito da cliccare su chat archiviate. Non è una questione di forza di volontà. È il cervello umano. Funziona così. Non è possibile spegnerlo. Impossibile azzerare il continuum dei suoi pensieri. Per alcuni, funziona la distrazione. Decidere razionalmente di non pensare a ciò che ti provoca timore, disagio, dolore. Altri, scuotono fisicamente la testa. Altri ancora si lanciano in organizzazioni certosine di folli orari di lavoro, alternati a turni in palestra, pulizie di primavera in pieno inverno, shopping compulsivo, corsi di cucina, disegno, cucito e canti sciamanaci. Tutto pur di non pensare. Per me, no. È, alquanto, ovvio. Sono una maniaca del controllo e, l’idea di non controllare i miei stessi pensieri, è la mia principale fonte di stress. Sono anche un’egocentrica, come si evincerà da queste poche righe. Una che pensa di potersi sostituire a Dio o a chiunque sia da quelle parti a governare il fato. Ho scoperto nel tempo, che l’unica cosa che funzioni con me è: osservare i miei pensieri. Senza giudicarli. Fingendo che non siano nemmeno partoriti dalla mia mente, ma siano, invece, una qualche forma di vita indipendente da me. Non mi interessa spiegarli, mi interessa osservarli.
Con le persone che mi feriscono, con quelle che ferisco, con quelle che archivierei e con quelle che, in effetti, archivio mi impegno a fare lo stesso.
Devo guardarle andar via. Fissare nella mia mente le sagome delle loro spalle e lavorare da dentro. Ricordare, ogni volta, come siamo arrivati a dirci addio e far sì, che quell’addio, resti tale.
Almeno dentro me.
Dico addio infinite volte dentro me. Raramente lo dico di persona. Tuttavia, quando dentro me scatta, è impossibile non notarlo. Non credo sia utile palesarlo. Fa solo più male. Le persone, quando si sentono dire addio, cercano di correre ai ripari senza capire che è già troppo tardi. Quando la parola sboccia dentro te, è abbastanza perentoria e definitiva, altrimenti diremmo arrivederci, considerato che non siamo spagnoli. Almeno quando è semplice, cerchiamo di non mortificare la nostra meravigliosa lingua.
Come si arrivi a quell’addio conta poco. Dentro me rievoca una condizione di abbandono. L’abbandono, insieme ai miei pensieri abbandonici, è un’altra cosa che non so controllare, una fonte inesauribile di dolore. Per anni, mi sono immersa in quella fonte, in una forma di indolente piacere, fino a quando un giorno in cui, il sole non brillava particolarmente, i punti cardinali non si erano affastellati e la testa ancora era sul mio collo, ho capito quanto tossico fosse quell’atteggiamento. Sono cresciuta, direbbe qualcuno.
È successo che ho capito che il problema dell’abbandono non è solo in chi crede di subirlo quanto, invece, in chi lo agisce. Sempre. Anche, forse soprattutto, quando quella che abbandona, sono io. Questo cambio di prospettiva ha reso possibile dentro me il perdono e mi ha liberata.
Certo, mi provoca ancora un’ira funesta, quel nervo scoperto. Sento l’orgoglio bruciare misto alla presunzione, che mi riconosco e detesto del pensare: “Come osi non amarmi fino allo sfinimento”? Poi però mi fermo. Cerco di placare il mio smisurato ego. Respiro profondamente e osservo. Forse la mia nozione di sfinimento non è come la tua? Forse la mia percezione di me è lontana da quella che hai tu di me? Forse, più verosimilmente, hai deciso di andare via punto e non c’è nulla da fare al riguardo? Ascoltate, la libertà di queste parole.
Non c’è n u l l a da fare. Non c’è un perché. Piantala di cercarlo. Piantala di cercare la felicità dove, ormai è chiaro, non potrai trovarla.
C’è stato un tempo in cui non capivo la frase: la felicità è una scelta. Mi sembrava una corbelleria. Niente di più, niente di meno. Da buona maniaca del controllo, ego riferita e vittima di abbandono (auto diagnosticata e su questo dovremmo discutere perché è sintomatico della vera malattia) mi ero convinta che la felicità fosse una misteriosa condizione permanente, costituita da una serie di indecifrabili variabili. Un eccitante enigma da decifrare. Una specie di gioco dell’oca eterno. In questo interminabile ciclo di avanzamenti e retrocessioni di casella, mi illudevo di dover trovare indizi.
Ho vissuto buona parte della mia vita, convinta intimamente, che la felicità fosse una costruzione fatta coi blocchi della Lego e che, una volta raggiunta, una volta in possesso di tutti i blocchetti necessari, potevi assemblarla a tuo piacimento e poi distruggerla, ma quella felicità restava nelle tue mani.Te l'eri guadagnata. Che abominio! Come se la felicità fosse un premio e non una conditio sine qua non della vita umana.
Immaginate lo stress? Di una vita a passare in rassegna blocchetti di costruzioni inesistenti? Di una vita trascorsa a convincersi che quell’amica, quell’amore, fossero blocchetti di Lego a tua disposizione nel gioco perverso della tua personale ricerca della felicità? Ad ogni amore fallito, correre al successivo, con un nuovo blocchetto colorato, quindi, illudersi di poter ottenere giganti costruzioni, vedere, nuovamente, la struttura barcollare. Un altro giro, un’altra corsa. Sempre col cuore gonfio. Sempre col cuore in affanno. Sempre col cuore alla ricerca. Alla ricerca di cosa?
Immaginate la relativa frustrazione nel constatare, come era ovvio che fosse, che no, nessuno di loro era un blocchetto. Che le persone non sono intercambiabili come le costruzioni e che non è un loro compito rendermi, renderci, felici?
Ho dovuto sentire il peso della responsabilità per la mia esistenza schiacciarmi, per capire, che felice lo ero già. Da sola. Ma l’idea della felicità imperitura, è una perversione tutta squisitamente occidentale. Quando accetteremo che dolore e felicità non sono opposti, ma più semplicemente facce della stessa medaglia, impareremo a fare caso alla felicità.
Ho capito che le persone non le puoi archiviare, le devi lasciare andare e, ho compreso, che per farlo basta smetterla di demandare a loro quello che dovremmo fare noi. Non siamo tazze vuote. Non abbiamo bisogno di essere riempiti da una mano esterna. Dovremmo imparare tutti a bastarci. Suona un po’ qualunquista, lo so. Eppure, è l’unica cosa che davvero mi è chiara.
Non so voi come la vediate. So che l’unica strada per me, è capire. Osservare e domandare a me stessa: chi sono? Non è una risposta della mente quella che cerco. Non ho bisogno di sapere chi sono. Ho bisogno di capire, chi sono. È un lavoro incessante. Un quesito sempre aperto, che abita la parte preponderante della mia mente. Aspetto una risposta dal cuore. Nel frattempo, vivo. Resto nei miei vuoti e li osservo. Scrivo perché è ciò che mi mantiene onesta e attraverso le tempeste.